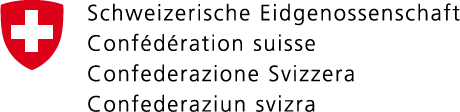Le condizioni di vita della popolazione rispecchiano lo spazio di manovra e le prospettive di vita di cui dispongono gli individui e riflettono i settori di intervento delle politiche sociali. Le condizioni di vita comprendono aspetti materiali (ad es. il reddito o l’alloggio) e immateriali (ad es. la formazione o la sanità).
Le risorse finanziarie influenzano le condizioni e il tenore di vita nonché il livello di consumo di beni e servizi. Esse possono essere causa di disuguaglianze a livello di risorse materiali (ad es. alloggio, beni di consumo materiali) e immateriali (ad es. formazione e sanità).
Nel 2020, il reddito disponibile equivalente mediano ammonta a 4048 franchi al mese. Ciò significa che la metà delle persone residenti in Svizzera ha un reddito superiore a questo valore, mentre l'altra metà ha un reddito inferiore. Questo reddito è salito del 16% tra il 2000 e il 2014. Dopo un aumento significativo dal 2008 al 2013, il reddito disponibile equivalente mediano ha subito una stagnazione tra il 2015 e il 2020. |
Nel periodo 2015–2017 il reddito disponibile di chi viveva solo era pari a 4529 franchi per le persone sotto i 65 anni e a 3339 franchi per gli ultrasessantacinquenni. Per le coppie sotto i 65 anni senza figli era di 8596 franchi e per le economie domestiche monoparentali tale reddito era di 5703 franchi, contro i 9346 per le coppie con figli.
Le competenze e le qualifiche ottenute tramite la formazione permettono di adattarsi alla società e a un’economia in costante evoluzione.
Nel 2022, il 13,9% della popolazione residente permanente di età compresa tra i 25 e i 64 anni non aveva completato alcuna formazione, il 41,4% aveva conseguito una formazione del grado secondario II (scuola di maturità, scuola di cultura generale o formazione professionale iniziale) e il 45,0% possedeva un diploma del grado terziario (formazione professionale superiore e scuole universitarie).
Nel 2021 un terzo della popolazione ha incontrato ostacoli per formarsi. Il 19,2% ha partecipato ad attività di formazione ma avrebbe desiderato formarsi ulteriormente mentre il 12,8% degli adulti desiderosi di seguire una formazione non ha partecipato ad alcuna attività in tal senso. I restanti due terzi sono soddisfatti della loro situazione in termini di formazione e si sono formati come desideravano (33,6%) o non hanno manifestato alcuna intenzione di formarsi (34,3%). |
Idealmente, il lavoro permette di sopperire finanziariamente ai propri bisogni, di sviluppare competenze e di realizzarsi a livello professionale e sociale. In presenza di condizioni di lavoro ottimali, le persone possono fare progetti a lungo termine, avere accesso a una buona sicurezza sociale e organizzare al meglio la propria quotidianità. Al contrario, quando il lavoro è accompagnato da condizioni non desiderate, la quotidianità può diventare sinonimo di precarietà.
La quota di persone occupate a tempo parziale (grado di occupazione inferiore al 90%) è passata dal 27,4% nel 1996 al 37,0% nel 2022. Tra gli uomini la quota raggiungeva solo il 18,7% (contro l’8,3% nel 1996) mentre tra le donne corrispondeva al 57,9% (contro il 52,2% nel 1996).
Nel 2022, l’7,7% delle persone occupate aveva più di un lavoro. Questa quota è sensibilmente progredita dal 1996 (4,8%). Il fenomeno è nettamente più diffuso tra le donne (10,0%) che tra gli uomini (5,7%). |
La salute condiziona in larga misura l’accesso al mercato del lavoro e la partecipazione alla vita sociale. Le disuguaglianze e gli svantaggi sociali che si accumulano durante il percorso di vita hanno ripercussioni sullo stato di salute e sui comportamenti in materia di salute, come il ricorso o la rinuncia a prestazioni del sistema sanitario.
In tutte le fasce di età e indipendentemente dal sesso, il modo di valutare il proprio stato di salute generale differisce molto a seconda del livello di formazione. Le persone senza formazione postobbligatoria definiscono molto meno spesso il loro stato di salute come buono o molto buono rispetto a quelle con una formazione superiore (il 65,3 contro l’86,6%).
Secondo l’indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC) del 2021, 1,6 milioni di persone di 16 anni e più che vivono in un’economia domestica privata hanno dichiarato di avere un problema di salute permanente e di essere limitate (fortemente o meno) nelle attività normali della vita. Queste persone sono di conseguenza considerate disabili ai sensi della legge sui disabili. Di queste, 340 000 hanno indicato di essere fortemente limitate (disabilità grave). A queste cifre tratte dall’indagine SILC si aggiungono i bambini al di sotto dei 16 anni e le persone che vivono in case per anziani o in altre economie domestiche collettive. La quota di persone disabili aumenta con l’età: solo l’11% dei giovani dai 16 ai 24 anni ha una disabilità, rispetto al 39% delle persone dagli 85 in su. Circa un terzo delle persone disabili ha più di 65 anni. Le donne sono colpite dalla disabilità (25%) leggermente più spesso degli uomini (19%).
La possibilità di conciliare la vita professionale e quella familiare influenza fortemente le decisioni che gli individui prendono in termini di figli, vita familiare, ripartizione dei ruoli nella famiglia, suddivisione delle attività retribuite e non retribuite e grado di occupazione.
Nel 2022 nelle economie domestiche composte da una coppia con figli nelle quali i due partner avevano tra i 25 e i 54 anni, il modello più diffuso era quello con il padre che lavora a tempo pieno e la madre a tempo parziale. Le famiglie in cui entrambi i partner lavorano a tempo parziale sono rare. Questo modello è però più di due volte più frequente nei casi in cui il figlio più giovane ha meno di 4 anni (11%) rispetto a quelli in cui ne ha tra i 13 e i 24 (5%). |
Avere un luogo dove stare e sentirsi a casa rappresenta un elemento centrale di copertura dei bisogni esistenziali. Una qualità di vita accettabile dipende infatti in larga misura dalla possibilità di usufruire di un alloggio sufficientemente grande, di qualità soddisfacente e a un prezzo accessibile.
Quasi il 12% delle persone sotto i 65 anni che vivono da sole e circa il 10% di coloro che vivono in famiglie monoparentali, dei disoccupati, delle persone a basso reddito e degli stranieri sono piuttosto insoddisfatti delle loro condizioni abitative (valori che vanno da 0 a 5 su una scala da 0 a 10), mentre la percentuale di persone insoddisfatte nell'intera popolazione è del 5,6%. Anche le persone senza formazione post-obbligatoria e gli inquilini sono più spesso insoddisfatti della loro abitazione rispetto alla media.
I legami sociali permettono di far fronte agli eventi critici della vita, favoriscono la realizzazione personale e il bisogno di riconoscimento degli individui, contribuendo a migliorare la salute fisica e mentale.
Tra la popolazione residente, il 95,8% delle persone afferma di avere parenti, amici o vicini a cui rivolgersi per chiedere un aiuto morale, materiale o finanziario in caso di problemi, mentre il resto non ha nessuno a cui rivolgersi. I gruppi di popolazione ai quali manca tale sostegno sono principalmente le persone con reddito basso, quelle di origine straniera le persone disoccupate e quelle senza formazione post-obbligatoria.
Oltre alle condizioni di vita evidenti e oggettive, anche il benessere soggettivo riveste una grande importanza. Per rilevarlo, si considera il punto di vista degli individui sulla propria esistenza.
La popolazione di 16 anni e più è molto soddisfatta della vita che conduce, con un valore medio di 7,9 su una scala da 0 («per niente soddisfatto») a 10 («del tutto soddisfatto»). Tuttavia, il 9,9% delle persone indica una soddisfazione bassa o abbastanza bassa (valori compresi tra 0 e 5); questa proporzione è particolarmente elevata tra le persone disoccupate, quelle al di sotto dei 65 anni che vivono sole e quelle a reddito basso. La percentuale di persone poco soddisfatte è relativamente alta anche tra le persone senza formazione post-obbligatoria.
Informazioni supplementari
Temi correlati
Lavoro e reddito
Formazione e scienza
Stato di salute
Situazione economica e socilale della popolazione
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Aiuto socialeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 461 44 44